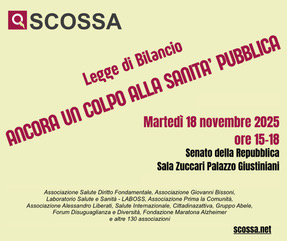La Legge finanziaria 2026, che arriverà nelle prossime settimane in Parlamento, dedica alla prevenzione l’Articolo 64 (Misure di prevenzione), che si compone di quattro commi.
Il comma 1 stabilisce un finanziamento di 238 milioni di euro per:
- a. il potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
- b. Il potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
- c. la prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore, nell’ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma.
Tale finanziamento deve inoltre concorrere al rimborso alle Regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale, incrementando l’apposito fondo previsto da norme precedenti.
Al comma 2 la norma prevede, per l’anno 2026, un ulteriore importo, aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 1, pari a 247 milioni di euro (127 derivanti dalla precedente legge di bilancio del 2025; 120 sul fabbisogno sanitario standard dell’articolo 63 di questa stessa normativa).
Con il comma 3 vengono stanziati 1 milione di euro (dalle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale) per la realizzazione, a cura del Ministero della salute, di campagne di comunicazione sulla prevenzione.
Il comma 4 prevede che i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1 siano definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell’anno di riferimento.
Se ne deduce, in sostanza, che i fondi per la prevenzione salgono dal 5% al 5,2% in modo strutturale. Per il resto si tratta di un aumento temporaneo in parte finanziato con un fondo, costituito nel precedente anno, che ora usano – o indicano di usare – secondo alcuni obiettivi.
Il fatto che emerga un incremento dei finanziamenti destinati alla prevenzione e, nello specifico, a questi screening, risulta certamente positivo.
La lettura del testo tuttavia ci conferma – se ve ne fosse bisogno – che le politiche sanitarie sono decise o quantomeno definite/delineate in sede del Ministero della Economia e Finanze (MEF), cosicché il loro effettivo risultato, in termini di efficacia sugli obiettivi dichiarati, appare assolutamente aleatorio.
Vengono modificati, con questa Legge di bilancio, i due screening oncologici sopra richiamati, normati dal Ministero della salute attraverso il Piano Oncologico Nazionale (documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro, 2023-2027) e definiti, sotto il profilo giuridico, dai
Livelli essenziali di assistenza (LEA) sin dal 2001 e confermati dal DPCM 12 gennaio 2017. È opportuno richiamare all’attenzione del lettore che il DPCM che stabilisce i Lea si avvale del parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La domanda che inevitabilmente ci si pone è se la procedura sia corretta e perfino legittima.
Ci si attenderebbe infatti che si introducesse una modifica o aggiornamento al Piano Oncologico Nazionale sulla base di una valutazione costi-benefici dell’ampliamento delle summenzionate fasce di età.
Conseguentemente un aggiornamento dei Lea per il quale è necessario il parere delle Commissioni parlamentari (un dato non trascurabile del rapporto Governo – Parlamento) e in particolare della Conferenza Stato – regioni.
Sono infatti le Regioni che dovranno organizzare questa attività, acquisire i dati sulle persone da invitare, trasmettere i risultati dell’attività all’Osservatorio Nazionale Screening, mettere a disposizione attrezzature e personale non solo per lo screening, ma anche per il percorso successivo per i casi risultati positivi ai test.
In assenza di tali iniziative sarà inevitabile che il finanziamento non venga utilizzato o finalizzato, di fatto, ad altra attività.
Inoltre, se non si attua una modifica dei Lea, l’estensione dello screening è condizionata – finanziariamente – alla annuale legge di bilancio o a carico del bilancio di ciascuna Regione.
Al di là del fatto che la maggioranza delle Regioni impegnano, nell’ambito della Prevenzione, come evidenzia ripetutamente la Ragioneria Generale dello Stato, una spesa inferiore al 5% previsto dalla normativa (complessivamente a livello nazionale ci attestiamo al 4,5%), le problematiche rispetto agli screening oncologici non riguardano tanto la loro estensione – in termini di fasce di età – ma il diverso approccio da Regione a Regione e, prioritariamente, l’adesione della popolazione.
Per quanto riguarda il tumore del colon – retto la normativa in vigore (vale a dire il Programma nazionale screening e i livelli LEA) indica la fascia di età 50 – 69 anni con esame biennale.
Le Regioni, per quanto riguarda le fasce di età invitate, si suddividono in tre categorie:
- 1. Età 50 – 69 anni con esame biennale: Basilicata, Campania, Friuli Venezia- Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.
- 2. Età 50- 74 anni con esame biennale: Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Veneto.
- 3. Età 50 – 69 anni con esame biennale + 70 – 74 anni con esame annuale: Emilia – Romagna, Marche.
Tuttavia l’elemento più rilevante è la differenza di adesione al test, come attesta l’Osservatorio nazionale Screening per il 2024: a fronte di una media italiana di “adesione corretta” del 35,8%, il Nord arriva al 46,8%, il Centro al 32,7%, il Sud 21,1%.
Più accentuate le differenze interregionali: Valle d’Aosta il 66,4%, Veneto il 61,7%; all’estremo opposto la Calabra 5,2% e la Sicilia 15,4%.
Pertanto, se alcuni programmi di estensione di tale screening da parte delle Regioni sono perseguibili, o già perseguiti, assestandosi la partecipazione al di sopra della media nazionale, altre realtà (fra cui, ad esempio Campania, Lazio, Puglia) sono nettamente sotto la media; il loro obiettivo prioritario dovrebbe pertanto essere quello di incentivare la partecipazione della popolazione a cui l’offerta di screening è già in atto.
Per quanto riguarda lo screening per il tumore del seno la variabilità di approccio fra le Regioni è assai più ampia, sia in termini di fasce di età che di periodizzazione, con ben sei differenti criteri, come si desume dal sito dell’AIRC che titola, non a caso: “Screening oncologici in ogni Regione: mettiamo ordine”.
- 1. Puglia, Sardegna, Abruzzo, Molise si attengono alle indicazioni nazionali: 50 – 69 con mammografia ogni due anni.
- 2. Friuli Venezia Giulia ha abbassato l’età di ingresso: 45 – 69 anni.
- 3. Lazio e la Calabria hanno allungato l’uscita dallo screening: 50 – 74 anni.
- 4. Marche ha definito questa fascia di età: 45 – 74 anni.
- 5. Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto hanno adottato un programma più esteso e più intensivo: 45 – 49 annuale + 50 –74 biennale a cui ha aderito anche il Piemonte tuttavia con adesione spontanea tra i 70 e i 75 anni.
- 6. La Campania infine si caratterizza per diversità anche all’interno del proprio territorio: 45 – 69 in quattro Asl, 50 – 69 in tre Asl.
Queste diversità non appaiono – tutte – giustificate. Per quanto riguarda il tumore della mammella e la “calibrazione” costi/rischi- benefici vi sono approcci diversi.
Ad esempio le linee guida dell’Americana Cancer Society suggeriscono (have the option to start) una mammografia annuale fin dai 40 anni, ma dai 45 il suggerimento diventa una netta indicazione (should get), sostanzialmente per tutta la vita in buona salute, (con una partecipazione del 74% fra le assicurate, a fronte del 37% fra le non assicurate).
Diverso è l’approccio in Inghilterra e Scozia, dove il NHS offre lo screening con esame triennale dai 50 ai70 anni (partecipazione 2023 – 2024 = 70,0%). Successivamente è possibile ripresentarsi spontaneamente ogni tre anni.
Le scelte fino ad ora indicate possono logicamente essere oggetto a modifiche, in base ai risultati della letteratura e alla introduzione di nuove tecnologie, che migliorano la diagnostica e riducono le radiazioni.
Un ampliamento della offerta appare appropriato là dove, fra i 50 e i 69 anni, si è raggiunta una adeguata copertura (adesione corretta), come ad esempio in Veneto (75,9%), Emilia-Romagna (73,9%), Toscana (67,4%), Meno comprensibili appaio invece le iniziative di ampliamento, già in atto, del Lazio e delle Marche con una copertura nella fascia di età maggiormente a rischio: rispettivamente del 43,6% e del 46,2%; ancor più particolari le iniziative di ampliamento in Campania con una adesione allo screening del 33,5% e in Calabria dove l’adesione si ferma al 22,1%!
Vi è inoltre un altro elemento da considerare: a livello territoriale tutte le regioni del Sud Italia, oltre al Lazio, la Liguria e le Marche, sono al di sotto della media nazionale (53,8%), ma presentano i livelli piùelevati di esami mammografici al di fuori dello screening del SSN (accertamenti “spontanei”), non raggiungendo tuttavia, in queste regioni, la complessiva (screening + autopresentazione) media nazionale.
L’accesso alla mammografia, al di fuori dello screening organizzato, ha tuttavia una caratteristica che si chiama “disuguaglianza”, come si evidenzia in base ai livelli di istruzione e alla cittadinanza.
Alla mammografia, al di fuori dello screening organizzato, vi ricorrono infatti il 30% delle laureate a fronte dell’11% di donne con nessuna istruzione o istruzione elementare; ancora più rilevanti le differenze in termini di nazionalità: 21% di italiane o provenienti da PSA (Paesi a sviluppo avanzato) contro il 9% di stranieri provenienti da Paesi a forte pressione migratoria.
Tali differenze, ovvero tali rilevanti diseguaglianze, non sussistono all’interno del programma di screening del Servizio sanitario nazionale.
Una iniziativa adeguata, nell’ambito di tali programmi di prevenzione oncologica, dovrebbe pertanto mirare a:
- 1. Definire una strategia comune fra le Regioni, con differenziazioni (incrementi dell’offerta per fasce di età e frequenza) sulla base degli obiettivi raggiunti.
- 2. Promuovere forme di partenariato fra Regioni, finalizzate ad esportare le migliori pratiche nelle Regioni che hanno una adesione inferiore alla media nazionale.
- 3. Mettere a punto iniziative specifiche mirate al superamento delle diseguaglianze con informazione mirata (anche linguistica) e offrire una prossimità di erogazione della prestazione, finalizzata a un riequilibrio di adesione e appropriatezza fra territori e fasce di popolazione (zone interne, gruppi svantaggiati ecc.).
- 4. Disincentivare, eliminando eventuali esenzioni fiscali e con un’azione di confronto con le organizzazioni sindacali su tale questione, le attività di (pseudo) prevenzione in tale ambito. Tali iniziative sono un elemento di “inquinamento” delle attività di screening programmato, poiché causano una duplicazione di accertamenti con una sovraesposizione a radiazioni, una non rispondenza all’invito da parte del Ssn, con aggravi per il servizio (nuovo richiamo ecc.), una potenziale over diagnosi con conseguenti successivi accertamenti.
Marco Geddes da Filicaia
© RIPRODUZIONE RISERVATA